 Cos'è il Bio
Per l’agricoltura
biologica la qualità è plurale. Ci sono, infatti, le quattro qualità che
derivano dalla semplice applicazione delle norme di produzione europee (Reg. CEE
2092/91 e allegato I, parte B del regolamento (CEE) n. 2092/91, modificato nel
luglio 1999 dal regolamento (CE) n. 1804/99). Si tratta dunque di qualità certe
e dovute che riguardano il migliore impatto ambientale, la salubrità, l’assenza
di OGM e la garanzia del sistema di controllo e certificazione. Ci sono, poi, altre
qualità che riguardano caratteristiche non espressamente richieste dal
Regolamento comunitario ma che i produttori, singoli o associati, possono
decidere di attribuire ai loro prodotti applicando regole aggiuntive, o
comportamenti particolari. Fra queste qualità, che sono in continua evoluzione,
ricordiamo quelle del commercio equosolidale, della sovranità alimentare e della
costruzione di un nuovo rapporto fra città e campagna.
Più salute con gusto
Sicurezza igienico-sanitaria, contenuto nutrizionale e qualità organolettica, in
altre parole nutrirsi con gusto: questo è quello che ciascuno di noi vuole dal
cibo che porta a tavola.
I prodotti biologici, proprio per le tecniche agronomiche adottate, in
particolare il non uso di sostanze chimiche di sintesi, sono di norma più sicuri
degli altri dal punto di vista igienico-sanitario. Diverse ricerche dimostrano,
poi, che il valore nutritivo dei prodotti biologici è spesso superiore a quello
dei prodotti convenzionali. In particolare è stato rilevato di frequente una
maggiore presenza di preziose sostanze antiossidanti. Infine, nei pochi studi
che mettono a confronto il gusto dei prodotti convenzionali e di quelli
biologici, questi ultimi si collocano in genere al livello della qualità
medio-alta dei primi. È sempre più frequente, infine, il buon posizionamento dei
prodotti biologici nei concorsi.
Più amico dell’ambiente
Inquinamento di aria, acqua e suolo; erosione e perdita di fertilità del suolo;
riduzione della biodiversità; elevati consumi energetici e produzione di gas
serra (il “contributo” dell’agricoltura è stimato attorno al 7%): questi sono
alcuni dei problemi creati dall’agricoltura convenzionale e che nemmeno la sua
versione geneticamente modificata è in grado di risolvere, anzi.
Su tutti questi problemi l’agricoltura biologica ha invece dimostrato di essere
capace di offrire delle soluzioni, sia attraverso l’applicazione del Regolamento
Cee, sia attraverso regole più restrittive adottate volontariamente dagli
agricoltori. L’agricoltura biologica, infatti, riduce al minimo il rilascio di
residui nel terreno, nell’aria e nell’acqua, conserva la naturale fertilità del
suolo, salvaguarda la complessità dell’agroecosistema e la sua biodiversità,
consuma meno energia.
Libertà dagli OGM
Nel 1991, quando fu approvato il Regolamento Cee per l’agricoltura biologica,
gli OGM – Organismi Geneticamente Modificati – erano molto meno noti e,
soprattutto, erano molto meno diffusi di quanto lo sono oggi. Eppure, già allora
un articolo di quel regolamento ne vietava espressamente l’uso in agricoltura
biologica. Il movimento internazionale per l’agricoltura biologica, che aveva
voluto e promosso quel regolamento, aveva intuito le incognite e i rischi insiti
nell’uso di OGM in agricoltura.
Come è risultato più chiaro dopo, si tratta di incognite e rischi che investono
l’ambiente, la salute umana e la stessa possibilità dei popoli di scegliere cosa
produrre e come alimentarsi. La strada proposta dall’agricoltura geneticamente
modificata è l’opposto di quella proposta dall’agricoltura biologica: per questo
la loro coesistenza è impossibile.
Sai cosa mangi
Sapere cosa si mangia significa conoscere nelle linee essenziali in che modo un
alimento è prodotto in tutti i suoi passaggi, dal campo al punto vendita. Perché
ciò sia possibile almeno due condizioni sono necessarie: un insieme di regole
cui deve sottostare la produzione e la distribuzione di un cibo, uno o più
organismi indipendenti che controllano l’applicazione delle norme e la
certificano ai consumatori.
Questo è ciò che accade per i prodotti biologici, con l’applicazione del
Regolamento Cee 2092/91, attraverso un’attività di ispezione che investe sia il
processo produttivo, sia il prodotto finale, dal campo alla tavola. Si tratta di
un sistema sicuramente suscettibile di miglioramento e attualmente, a oltre
vent’anni dall’inizio della sua applicazione, è sottoposto a un processo di
revisione. Tuttavia, quello del biologico è ancora oggi quello che, almeno in
campo alimentare, offre maggiori garanzie.
2 |
|
L'agricoltura
biologica è un metodo di produzione definito dal punto di vista legislativo a
livello comunitario con un primo regolamento, il Regolamento CEE 2092/91,
sostituito successivamente dai Reg. CE 834/07 e 889/08 e a livello nazionale con
il D.M. 18354/09.
Il termine
"agricoltura biologica" indica un metodo di coltivazione e di allevamento che
ammette solo l'impiego di sostanze naturali, presenti cioè in natura, escludendo
l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi).
Agricoltura biologica significa sviluppare un modello di produzione che eviti lo
sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, in particolare del suolo,
dell'acqua e dell'aria, utilizzando invece tali risorse all’interno di un
modello di sviluppo che possa durare nel tempo.
Per salvaguardare la fertilità naturale di un terreno gli agricoltori biologici
utilizzano materiale organico e, ricorrendo ad appropriate tecniche agricole,
non lo sfruttano in modo intensivo.
Per quanto riguarda i sistemi di allevamento, si pone la massima attenzione al
benessere degli animali, che si nutrono di erba e foraggio biologico e non
assumono antibiotici, ormoni o altre sostanze che stimolino artificialmente la
crescita e la produzione di latte. Inoltre, nelle aziende agricole devono
esserci ampi spazi perché gli animali possano muoversi e pascolare liberamente.
Le coltivazioni
In agricoltura biologica non si utilizzano
sostanze chimiche di sintesi (concimi, diserbanti, anticrittogamici,
insetticidi, pesticidi in genere). Alla difesa delle colture si provvede
innanzitutto in via preventiva, selezionando specie resistenti alle malattie e
intervenendo con tecniche di coltivazione appropriate, come, per esempio:
la rotazione delle colture: non coltivando consecutivamente sullo stesso terreno
la stessa pianta, da un lato si ostacola l'ambientarsi dei parassiti e
dall'altro si sfruttano in modo più razionale e meno intensivo le sostanze
nutrienti del terreno;
la piantumazione di siepi ed alberi che, oltre a ricreare il paesaggio, danno
ospitalità ai predatori naturali dei parassiti e fungono da barriera fisica a
possibili inquinamenti esterni;
la consociazione: coltivando in parallelo piante sgradite l'una ai parassiti
dell'altra.
In agricoltura biologica si usano fertilizzanti naturali come il letame
opportunamente compostato ed altre sostanze organiche compostate (sfalci, ecc.)
e sovesci, cioè incorporazioni nel terreno di piante appositamente seminate,
come trifoglio o senape.
In caso di necessità, per la difesa delle colture si interviene con sostanze
naturali vegetali, animali o minerali: estratti di piante, insetti utili che
predano i parassiti, farina di roccia o minerali naturali per correggere
struttura e caratteristiche chimiche del terreno e per difendere le coltivazioni
dalle crittogame.
Il ricorso a tecniche di coltivazione biologiche ricostruisce l’equilibrio nelle
aziende agricole; qualora, comunque, si rendesse necessario intervenire per la
difesa delle coltivazioni da parassiti e altre avversità, l’agricoltore può fare
ricorso esclusivamente alle sostanze di origine naturale espressamente
autorizzate e dettagliate dal Regolamento europeo (con il criterio della
cosiddetta “lista positiva”).
Gli allevamenti

Anche l’allevamento biologico segue criteri
normativi definiti dall’Unione Europea, attraverso il Regolamento CE 1804/99 e a
livello nazionale con il D.M. n.91436 del 4 Agosto 2000.
Principi generali
Gli animali devono essere alimentati secondo i loro fabbisogni con prodotti
vegetali ottenuti con metodo di produzione biologico, coltivati di preferenza
nella stessa azienda o nel comprensorio in cui l'azienda ricade.
L'allevamento degli animali con metodo biologico è strettamente legato alla
terra. Il numero dei capi allevabili è in stretta relazione con la superficie
disponibile.
I sistemi di allevamento adottati devono soddisfare i bisogni etologici e
fisiologici degli animali. Pertanto essi devono consentire agli animali allevati
di esprimere il loro comportamento naturale e debbono garantirgli sistemi di
vita adeguati.
Sono vietati il trapianto degli embrioni e l'uso di ormoni per regolare
l'ovulazione eccetto in caso di trattamento veterinario di singoli animali.
L'impiego di razze ottenute mediante manipolazione genetica è vietato.
Il trasporto del bestiame deve essere quanto più breve possibile ed effettuarsi
in modo da affaticare il meno possibile gli animali. Le operazioni di carico e
scarico devono effettuarsi senza brutalità. E' vietato l'uso di calmanti durante
il tragitto.
Il trattamento degli animali al momento della macellazione o dell'abbattimento
deve limitare la tensione e, nello stesso tempo, offrire le dovute garanzie
rispetto all'identificazione e alla separazione degli animali biologici da
quelli convenzionali.
Scelta delle razze
E' preferibile allevare razze autoctone, che siano ben adattate alle condizioni
ambientali locali, resistenti alle malattie e adatte alla stabulazione
all'aperto.
Ricoveri e norme igieniche
Le condizioni di allevamento devono tenere conto del comportamento innato degli
animali. In particolare. le strutture per l'allevamento devono essere salubri,
correttamente dimensionate al carico di bestiame e devono consentire
l'isolamento dei capi che necessitano di cure mediche. Inoltre devono essere
assicurati sufficiente spazio libero a disposizione degli animali. Per ogni
specie e categoria di animali il Regolamento CE 1804/99 definisce degli spazi
minimi che devono essere garantiti sia al coperto (in stalle, ricoveri) sia
all'aperto (paddock e altro).
Alimentazione
La dieta deve essere bilanciata in accordo con i fabbisogni nutrizionali degli
animali. Il 100% degli alimenti dovrebbe essere di origine biologica
controllata. Tuttavia, poiché ci possono essere delle difficoltà
nell'approvvigionamento di alimenti biologici, è consentito l'impiego di
alimenti non biologici fino al limite massimo del 10 % per i ruminanti e del 20%
per gli altri animali, calcolati sulla sostanza secca della razione alimentare.
Tale deroga è applicabile comunque solo fino al 24 agosto 2002.
Non possono comunque mai essere somministrati agli animali allevati con metodo
biologico: stimolatori di crescita o stimolatori dell'appetito sintetici;
conservanti e coloranti; urea; sottoprodotti animali (es. residui di macello o
farine di pesce) ai ruminanti e agli erbivori monogastrici, fatta eccezione per
il latte e i prodotti lattiero-caseari; escrementi o altri rifiuti animali;
alimenti sottoposti a trattamenti con solventi (es. panelli di soia o altri semi
oleosi) o addizionati di agenti chimici in genere; organismi geneticamente
modificati; vitamine sintetiche.
3
|
|
Norme sull'etichettatura
La garanzia che ci troviamo davanti ad un prodotto
proveniente da agricoltura biologica è data dall’etichettatura. Con il 1° luglio
2010 entra in vigore l’uso del nuovo logo europeo sulle etichette dei prodotti
biologici.
Normativa di riferimento
Innanzitutto, ecco i Regolamenti e Documenti a cui
ci riferiamo quando parliamo di etichettatura:
| Regolamento CE 834/07 e CE
889/08 |
Regolamenti attualmente in vigore per
l’Agricoltura biologica |
| Regolamento CE 271/10
|
Regolamento che definisce l’uso del
nuovo logo europeo e modifica alcune norme di etichettatura |
Cosa si definisce “etichetta”?
Le fascette, le etichette, gli imballaggi primari e
secondari che accompagnano il prodotto fino al consumatore costituiscono
“etichetta”, pertanto le indicazioni relative al metodo di produzione biologico
devono sempre rispettare quanto previsto dai regolamenti CE 834/07 e CE 889/08
ed essere autorizzate da un organismo di controllo a sua volta autorizzato dal
Ministero delle politiche agricole e forestali (Mi.P.A.A.F)
Quali prodotti agricoli possono
contenere riferimenti al biologico in etichetta?
-
il prodotto che è stato ottenuto
secondo le norme dell’agricoltura biologica o è stato importato da paesi
terzi nell'ambito del regime di cui ai Reg. CE 834/07 e CE 889/08;
-
il prodotto i cui ingredienti non
derivanti da attività agricola (additivi, aromi, preparazioni microrganiche,
sale, ecc.) e i coadiuvanti tecnologici utilizzati nella preparazione dei
prodotti rientrano fra quelli indicati nel Reg. CE 889/08
-
il prodotto i cui ingredienti il cui
ciclo produttivo sia totalmente libero da ogm
-
la materia prima (ingrediente)
«biologica» non è stata miscelata con la medesima sostanza di tipo
convenzionale
-
il prodotto o i suoi ingredienti non
sono stati sottoposti a trattamenti con ausiliari di fabbricazione e
coadiuvanti tecnologici diversi da quelli consentiti nel regolamento del
biologico, e che non abbiano subito trattamenti con radiazioni ionizzanti
Nell’etichettatura di un prodotto agricolo vivo o non trasformato, si possono
usare termini riferiti al metodo di produzione biologico a condizione che tutti
gli ingredienti di tale prodotto, siano stati ottenuti conformemente alle
prescrizioni di cui ai punti 1) 2) 3) 4)
Chi può etichettare?
Può etichettare un operatore
(agricoltore, distributore a marchio , importatore ) assoggettato alle misure di
controllo previste dai Reg. CE 834/07 e 889/08 e autorizzato da un organismo di
controllo riconosciuto.
Il logo europeo
Il logo europeo del biologico è stato scelto
attraverso un concorso internazionale tra più di 3400 bozzetti di studenti di
design , arrivati da tutti e 27 i paesi membri dell’Unione Europea. I tre loghi
finalisti sono stati poi votati sul web e si è aggiudicato la vittoria o
studente tedesco Dusan Milenkovic, con la proposta intitolata 'Euro-leaf'. (euro
–foglia). Il logo rappresenta infatti una foglia stilizzata disegnata con le
stelline dell’unione europea.
Inoltre dall’entrata in vigore del Reg.CE 271/10 il logo viene così definito:
«Logo di produzione biologica dell’Unione europea»
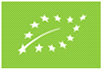
Nelle etichette stampate dopo il 1°luglio 2010
entra in vigore il nuovo logo europeo
Il logo europeo deve avere queste
caratteristiche:
-
altezza almeno 9 mm
-
larghezza 13,5 mm
-
proporzione tra altezza e larghezza
deve essere 1:1,5
-
per le confezioni molto piccole al
dimensione minima può essere ridotta a 6 mm per l’altezza
-
il colore di riferimento in pantone
è verde n.376 e se usiamo la quadricromia il verde ottenuto con
50%ciano+100%giallo
-
può essere stampato anche in bianco
e nero quando non sia possibile farlo a colori
-
quando il logo europeo venisse
affiancato ad altri loghi con al proprio interno gli stessi colori anche se
non con la stessa sfumatura, il logo europeo può essere eseguito con i
colori dell’altro logo senza incorrere in non conformità
-
se il colore dello sfondo
dell’imballaggio o dell’etichetta è scuro, è possibile adoperare i simboli
in negativo servendosi del colore di fondo dell’imballaggio o dell’etichetta
-
nel caso in cui il simbolo risulti
scarsamente visibile a causa del colore adoperato nel simbolo o nello sfondo
del medesimo, si può tracciare un bordo esterno di delimitazione attorno al
simbolo stesso per farlo risaltare meglio sullo sfondo
-
in determinate circostanze del
tutto particolari in cui esistano indicazioni in un unico colore
sull’imballaggio, è possibile utilizzare il logo biologico dell’UE in questo
stesso colore
Quando si applica e su quali
prodotti?
-
Il logo europeo si DEVE apporre ai
prodotti chiusi confezionati ed etichettati, con una percentuale prodotto di
origine agricola bio di almeno il 95%
-
Il logo europeo è FACOLTATIVO nei
prodotti con le stesse caratteristiche ma provenienti da paesi terzi.
-
Il logo è PROIBITO nei prodotti con
un % bio inferiore al 95%.
-
In questo caso l’etichettatura del
prodotto riporterà queste informazioni:
Accanto al logo europeo vanno riportate le indicazioni necessarie per
identificare la nazione, il tipo di metodo di produzione, il codice
dell’operatore, il codice dell’organismo di controllo preceduto dalla
dicitura: Organismo di controllo autorizzato dal Mi.P.A.A.F
|
Organismo di controllo autorizzato da Mi.P.A.A.F |
Operatore controllato n. |
|
IT BIO 123
|
A 456
|
|
- IT = CODICE ISO che identifica il biologico come da art.58 paragrafo1
lettera a)
- BIO = a seconda dei paesi può diventare ORG,EKO come da art.58 paragrafo
1 lettera b)
- 123 codice numerico dell’organismo
di controllo come da art. 58 paragrafo 1 lettera c)
Accanto a queste informazioni, un’importante
novità, entra in etichetta il luogo di coltivazione del /dei prodotti.
Le indicazioni previste sono:
|
AGRICOLTURA UE |
per prodotti coltivati in
uno dei paesi comunitari |
|
AGRICOLTURA NON UE |
prodotti coltivati in
paesi terzi |
|
AGRICOLTURA UE / AGRICOLTURA NON UE |
prodotti contenenti
prodotti NON coltivati in parte in europa e in parte in paesi terzi |
Se un prodotto è costituito di
ingredienti coltivati in “solo”Italia, la dicitura AGRICOLTURA UE può essere
sostituita dal nome del paese es: “ITALIA”, ’etichetta sarà quindi così: |

L’agricoltura biologica è l’unica forma di
agricoltura controllata in base a leggi europee e nazionali.
Non ci si basa, quindi, su autodichiarazioni del produttore ma su un Sistema di
Controllo uniforme in tutta l’Unione Europea.
L’azienda che vuole avviare la produzione biologica notifica la sua intenzione
alla Regione e ad uno degli Organismi di controllo autorizzati.
L’Organismo procede alla prima ispezione con propri tecnici specializzati che
esaminano l’azienda e prendono visione dei diversi appezzamenti, controllandone
la rispondenza con i diversi documenti catastali, dei magazzini, delle stalle e
di ogni altra struttura aziendale.
Se dall’ispezione emerge il rispetto della normativa, l’azienda viene ammessa
nel sistema di controllo, e avvia la conversione, un periodo di
disintossicazione del terreno che, a seconda dell’uso precedente di prodotti
chimici e delle coltivazioni può durare due o più anni.
Solo concluso questo periodo di conversione, il prodotto può essere
commercializzato come da agricoltura biologica.
L’Organismo provvede a più ispezioni l’anno, anche a sorpresa, e preleva
campioni da sottoporre ad analisi.
Le aziende agricole che producono con il metodo biologico devono poi documentare
ogni passaggio su appositi registri predisposti dal Ministero, ciò assicura la
totale tracciabilità.
Gli organismi di controllo italiani

Gli organismi nazionali che possono effettuare i
controlli e la certificazione delle produzioni biologiche sono nove, questi sono
riconosciuti con decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali, e
sono sottoposti a loro volta al controllo dello stesso ministero e delle
regioni.
Ecco i nomi e il loro codice identificativo:
-
ICEA - Istituto per la Certificazione
Etica e Ambientale, codice IT ICA (ex AIAB)
-
BIOAGRICERT - Bioagricoop, codice IT
BAC
-
BIOS, codice IT BIO
-
C.C.P.B. Consorzio Controllo Prodotti
Biologici, codice IT CPB
-
CODEX, codice IT CDX
-
ECOCERT Italia, codice IT ECO
-
I.M.C. Istituto Mediterraneo di
Certificazione, codice IT IMC
-
QC&I International services, codice
IT QCI
-
SUOLO E SALUTE, codice IT ASS
-
BIOZERT, codice IT BZT
Il metodo produttivo
È definito dal punto di vista legislativo a
livello comunitario con il Regolamento CEE 2092/91, e a livello nazionale con il
D.M. 220/95.
Agricoltura biologica significa sviluppare un modello di produzione che eviti lo
sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, in particolare del suolo,
dell'acqua e dell'aria. Per salvaguardare la fertilità naturale di un terreno
gli agricoltori biologici utilizzano materiale organico e, ricorrendo ad
appropriate tecniche agricole, non lo sfruttano in modo intensivo.
Per quanto riguarda i sistemi di allevamento, si pone la massima attenzione al
benessere degli animali, che si nutrono di erba e foraggio biologico e non
assumono antibiotici, ormoni o altre sostanze che stimolino artificialmente la
crescita e la produzione di latte.
Il settore produttivo
Il settore dai suoi albori, venti-trenta anni fa,
ha subito una vera mutazione antropologica. Accanto alla realtà storica di
piccole e piccolissime aziende - che hanno fatto da battistrada e ora rischiano
l’emarginazione - sono cresciute realtà aziendali molto diverse tra loro e non
solo nell’ambito agricolo, ma anche in quello della trasformazione e della
distribuzione (che resta l’anello più debole).
Ammesso che sia mai stato vero, oggi bio non è più sinonimo di brutto ma sano e
giusto, anche se non così buono. Oggi non c’è degustazione o ricerca nella quale
il biologico non si collochi al livello delle qualità medio alte degli altri
prodotti. Ciò grazie alla crescita delle capacità di produrre qualità sia sul
campo che nel post raccolta (confezionamento, conservazione, trasformazione…).
Il movimento
Si può dire che l’esistenza di un Regolamento sul
biologico e di un settore produttivo vitale sia in larga parte il frutto della
spinta prodotta dal “movimento”. Ora però entrambi hanno acquistato autonomia.
Basti pensare che quando è nato il regolamento Ue l’unica lobby che cercava di
condizionarne i contenuti era quella delle associazioni degli agricoltori
biologici. Oggi a quella degli agricoltori si è aggiunta quella degli organismi
di controllo, quella dell’industria di trasformazione, e via dicendo. Oggi è il
“movimento” a dover riacquistare spazio e autonomia con i suoi contenuti
sociali, culturali e politici fondandoli su questa nuova realtà.
AIAB, lavora in questa prospettiva come associazione che riunisce al suo interno
produttori, tecnici, consumatori, ricercatori e che persegue l’obiettivo di
contribuire attraverso l’agricoltura biologica alla definizione di un diverso
modello di sviluppo agricolo e della società nel suo insieme, ecologicamente e
socialmente più sostenibile.
(Fonte: www.aiab.it)
Organismi di controllo
Gli organismi di controllo autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole
(Mipaaf) per le produzioni biologiche sono enti di certificazione (elenco
disponibile
https://www.politicheagricole.it/ a cui la legge assegna il compito di
verificare il rispetto dei regolamenti attuativi da parte delle aziende
biologiche e concedere il proprio marchio da apporre alle etichette dei prodotti
venduti dall'azienda associata. Tali organismi devono rispettare il principio di
"terzietà" non intrattenendo altri rapporti commerciali o di consulenza con le
aziende certificate; le Regioni e le Province a statuto speciale sono preposte
al controllo di questo aspetto.
Politica Agricola Comune (Fonte:
https://www.politicheagricole.it/ )
La Politica Agricola Comune (PAC) rappresenta
l'insieme delle regole che l'Unione europea, fin dalla sua nascita, ha inteso
darsi riconoscendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e
stabile dei Paesi membri.
La PAC, ai sensi dell'articolo 39 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
europea, persegue i seguenti obiettivi: incrementare la produttività
dell'agricoltura; assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola;
stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori.
Politica Agricola Nazionale (Fonte:
https://www.politicheagricole.it/ )
Il Dipartimento delle politiche competitive, della
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca si occupa della qualità dei
prodotti e della valorizzazione del Made in Italy. Dall'agroalimentare alla
pesca, dai prodotti biologici al settore ippico, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali è in campo per la tutela del Made in Italy.
Il settore primario è per l'Italia una vera e propria risorsa. In termini
economici, per il valore aggiunto generato l'agricoltura, con le produzioni
agroalimentari, rappresenta uno dei settori produttivi più importanti con
oltre 260 miliardi di euro di fatturato dal sistema nel suo complesso.
Controlli
I prodotti enogastronomici del Made in Italy
rappresentano un patrimonio inestimabile del nostro Paese. I risultati di
eccellenza raggiunti dalle produzioni italiane sono resi possibili anche grazie
all'attenta azione di verifiche, controlli e sanzioni che permettono di
contrastare i fenomeni di contraffazione assicurando ai consumatori l'alta
qualità dei prodotti.
Il Ministero delle politiche agricole porta avanti un'azione capillare di
contrasto agli illeciti attraverso gli organismi di controllo
■ ICQRF - Ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari
■ Corpo Forestale dello Stato
■ NAC - Nucleo Antifrodi Carabinieri
■ Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
Prodotti DOP e IGP
L'Italia è il Paese europeo con il maggior
numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione
geografica riconosciuti dall'Unione europea. Un'ulteriore dimostrazione
della grande qualità delle nostre produzioni, ma soprattutto del forte legame
che lega le eccellenze agroalimentari italiane al proprio territorio di origine.
Il sistema delle Indicazioni Geografiche dell'Ue, infatti, favorisce il
sistema produttivo e l'economia del territorio; tutela l'ambiente, perché il
legame indissolubile con il territorio di origine esige la salvaguardia degli
ecosistemi e della biodiversità; sostiene la coesione sociale dell'intera
comunità.
Allo stesso tempo, grazie alla certificazione comunitaria si danno maggiori
garanzie ai consumatori con un livello di tracciabilità e di sicurezza
alimentare più elevato rispetto ad altri prodotti.

288 prodotti DOP,IGP,STG
523 vini DOCG, DOC, IGT
(Fonte:
https://www.politicheagricole.it/ )
Riferimenti e siti esterni:
-
Sito del Ministero delle politiche agricole e
forestali, politicheagricole.it.
-
Sistema d'Informazione Nazionale
sull'Agricoltura Biologica costituito dal Ministero delle politiche agricole
e forestali e dalle Regioni, sinab.it.
-
AIAB - Associazione Italiana per l'Agricoltura
Biologica, aiab.it.
-
RIRAB - Rete Italiana per la Ricerca in
Agricoltura Biologica, rirab.it
-
Organic.Edunet Una base di dati che contiene
materiale didattico ed educativo sull'agricoltura biologica
-
Regolamento (CEE) n. 2091/91,
eur-lex.europa.eu.
-
Regolamento (CE) n. 834/07, eur-lex.europa.eu.
-
Regolamento (CE) n. 889/08 modificato dal
Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile
2013., eur-lex.europa.eu e gazzettaufficiale.it
-
DM 18354-09., eur-lex.europa.eu
|

